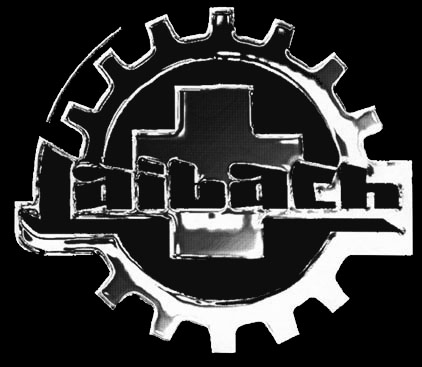Le canzoni d’amore sono noiose. L’amore è una cosa troppo importante per essere banalizzato, regolarmente, instancabilmente da mille canzonette o filmetti di quarta. Ma l’”amore” tira, da sempre. Nel suo nome, come nel nome della libertà, si perpetrano nefandezze culturali di imperdonabile gravità. Non c’è niente che vende, accarezza e rincoglionisce come l’”amore”. Così diverso dall’amore.
Le canzoni d’amore sono noiose. L’amore è una cosa troppo importante per essere banalizzato, regolarmente, instancabilmente da mille canzonette o filmetti di quarta. Ma l’”amore” tira, da sempre. Nel suo nome, come nel nome della libertà, si perpetrano nefandezze culturali di imperdonabile gravità. Non c’è niente che vende, accarezza e rincoglionisce come l’”amore”. Così diverso dall’amore.
Le canzoni d’amore che meritano davvero questo titolo sono poche. Non è mia intenzione enumerarne una lista, vista la detestabilità delle liste. Ma questa ve la voglio proporre perché secondo me è un autentico capolavoro, la cosa più bella della discografia intera di David Sylvian. Un brano imperfetto (la parte strumentale è una ticchia lunga, nonostante la magia ultramondana della tromba di Jon Hassell), che apre in maniera folgorante grazie a un testo che leva il fiato. Ogni volta che capita nel lettore, non posso continuare a fare quello che faccio. Mi devo fermare. Torno innocente di fronte alla bellezza.
Nella saturazione musicale delle nostre giornate siamo diventati come medici di fronte alla morte: il bello non ci commuove quasi più, diventa un sottofondo. Provate a chiedervi quanta musica è capace di distogliervi da quello che state facendo in questo momento, anziché accompagnarlo.
È amore vero quello espresso da Sylvian, non innamoramento (volendo noleggiare l’immagine da un immortale autore italiano che lasceremo anonimo), l’amore che non è possibile non vedere davanti a sé quando finalmente si crede ai propri occhi.
L’amore che nonostante tutto, quello che lead our life back to the soil.
When you come to me
I’ll question myself again
Is this grip on life still my own
When every step I take
Leads me so far away
Every thought should bring me closer home
And there you stand
Making my life possible
Raise my hands up to heaven
But only you could know
My whole world stands in front of me
By the look in your eyes
By the look in your eyes
My whole life stretches in front of me
Reaching up like a flower
Leading my life back to the soil
Every plan I’ve made’s
Lost in the scheme of things
Within each lesson lies the price to learn
A reason to believe
Divorces itself from me
Every hope I hold lies in my arms
And there you stand
Making my life possible
Raise my hands up to heaven
But only you could know
My whole world stands in front of me
By the look in your eyes
By the look in your eyes
My whole life stretches in front of me
Reaching up like a flower
Leading my life back to the soil
(1984)
Non solo grande musica: grande poesia, con la quale l’esile Sylvian, splendida versione umana di uno whippet, dimostrava chiaramente di volersi scrollare di dosso il “dandismo frivolo” dei Japan. E, manco a dirlo, ci riusciva brilliantemente.
Questa è la canzone da dedicare alla persona della vostra vita. Ma, se non avete ancora capito chi è, aspettate a fargliela ascoltare.