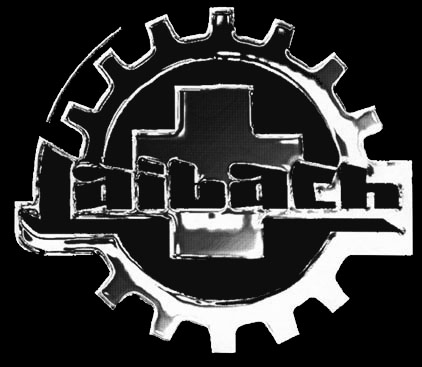Naturalmente, tutto il primo strepitoso disco dei Clash parla di quello che e’ successo qui a Londra. Ci sono differenze fondamentali fra questi riots e quelli di venticinque anni fa, ma le atmosfere descritte in quel folgorante esordio, teso, nervoso, nodoso, sono le stesse.
A molti viene da associare l’accaduto con “Anarchy in the Uk”, dei Pistols, ma non e’ un paragone abbastanza calzante, secondo me. E “London’s Burning” non e’ un pezzo sui riots, quanto sulla noia e l’alienazione che portano alla violenza, uno stadio precedente. Pezzi che parlano dell’esperienza conclamata della violenza sono “Police and Thieves”, qui sotto, “Cheat”, “Remote Control” e, naturalmente, “White Riot”.
Ma il brano che descrive meglio di qualunque altro quello che sta succedendo qui in questi giorni – se non altro per via della descrizione scientifica delle sensazioni di esaltazione date dal distruggere le cose degli altri – viene dai massimi Dead Kennedys e s’intitola, lapidariamente, “Riot”. Fa sembrare i Clash un gruppo quasi romantico, tanto ruvida, vuota e irredimibile e’ la violenza qui descritta. Perche’ questi riots hanno molto piu’ a che vedere con i disordini descritti dall’hardcore americano, da sempre depoliticizzato, che con quello londinese degli anni della Thatcher. Se questo brano eccezionale ha un “messaggio” (parola da talent show) e’ proprio quello dell’inutilita’ politica della violenza, anche quando sembri equivocamente esaltarne le caratteristiche.
Ho gia’ postato questo video in passato in occasione delle rivolte studentesche dei mesi scorsi, a cui tra l’altro si riferiscono alcune delle immagini montate con questo video, ma credo che vada riproposto, anche solo per via della performance di Jello Biafra, by far the most intelligent man in Hardcore Punk. L’aggettivo “viscerale” non le rende giustizia.
Rioting-the unbeatable high
Adrenalin shoots your nerves to the sky
Everyone knows this town is gonna blow
And it’s all gonna blow right now:.
Now you can smash all the windows that you want
All you really need are some friends and a rock
Throwing a brick never felt so damn good
Smash more glass
Scream with a laugh
And wallow with the crowds
Watch them kicking peoples’ ass
But you get to the place
Where the real slavedrivers live
It’s walled off by the riot squad
Aiming guns right at your head
So you turn right around
And play right into their hands
And set your own neighbourhood
Burning to the ground instead
[Chorus]
Riot-the unbeatable high
Riot-shoots your nerves to the sky
Riot-playing into their hands
Tomorrow you’re homeless
Tonight it’s a blast
Get your kicks in quick
They’re callin’ the national guard
Now could be your only chance
To torch a police car
Climb the roof, kick the siren in
And jump and yelp for joy
Quickly-dive back in the crowd
Slip away, now don’t get caught
Let’s loot the spiffy hi-fi store
Grab as much as you can hold
Pray your full arms don’t fall off
Here comes the owner with a gun
[Chorus]
The barricades spring up from nowhere
Cops in helmets line the lines
Shotguns prod into your bellies
The trigger fingers want an excuse
Now
The raging mob has lost its nerve
There’s more of us but who goes first
No one dares to cross the line
The cops know that they’ve won
It’s all over but not quite
The pigs have just begun to fight
They club your heads, kick your teeth
Police can riot all that they please
[Chorus]
Tomorrow you’re homeless
Tonight it’s a blast